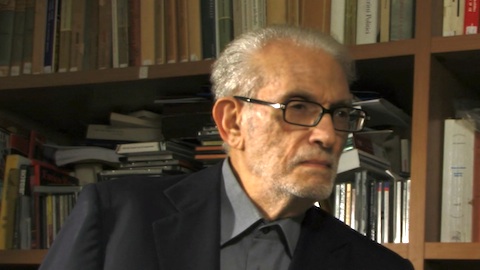TAORMINA. Attesissimo, si è svolto stamane l’incontro con l’attrice statunitense Lisa Edelstein. Bellissima ed elegante, la Edelstein – protagonista di Dr. House nei panni della dr.ssa Cuddy – aveva già attirato l’attenzione dei paparazzi giunti numerosi nella perla jonica e stamane, nell’incontro condotto dal direttore artistico del Taormina Film Festival, Mario Sesti, ha colpito il numeroso pubblico di appassionati e studenti “Campus”, predicando semplicità, impegno e divertimento, tanto nel lavoro che nella vita privata. Il fatto che l’attesa fosse grande è testimoniato dal fatto che Lisa Edelstein è stata protagonista per la prima volta di un incontro con collegamento internet in tempo reale con community di appassionati che sono intervenuti con domande e curiosità. Ma c’è stato spazio anche per sottolineare l’impegno civile dell’attrice, schierata a favore dell’aborto e dei diritti delle donne, degli omosessuali e dei transgender.
TAORMINA. Attesissimo, si è svolto stamane l’incontro con l’attrice statunitense Lisa Edelstein. Bellissima ed elegante, la Edelstein – protagonista di Dr. House nei panni della dr.ssa Cuddy – aveva già attirato l’attenzione dei paparazzi giunti numerosi nella perla jonica e stamane, nell’incontro condotto dal direttore artistico del Taormina Film Festival, Mario Sesti, ha colpito il numeroso pubblico di appassionati e studenti “Campus”, predicando semplicità, impegno e divertimento, tanto nel lavoro che nella vita privata. Il fatto che l’attesa fosse grande è testimoniato dal fatto che Lisa Edelstein è stata protagonista per la prima volta di un incontro con collegamento internet in tempo reale con community di appassionati che sono intervenuti con domande e curiosità. Ma c’è stato spazio anche per sottolineare l’impegno civile dell’attrice, schierata a favore dell’aborto e dei diritti delle donne, degli omosessuali e dei transgender.
Che rapporto hai con la celebrità?
«Non mi reputo famosa. Ho sempre voluto fare l’attrice, sin da quando ho memoria e aver partecipato al Dr. House è stata davvero una grande opportunità. La celebrità non è un mio obiettivo, piuttosto lo considerato un frutto del lavoro. Meglio fare ciò che piace senza pensare al successo che potrebbe scaturirne».
Con la dr.ssa Cuddy hai raggiunto una grande popolarità. Qual è il suo punto di forza?
«E’ una donna potente e coraggiosa, veste sempre in tailleur e ha molte responsabilità. Eppure non vuole rinunciare all’amore né alla maternità. Perché dovrebbe del resto? Ma vorrei che si divertisse di più…».
La dr.ssa Cuddy e House hanno, da subito, un rapporto di amore/odio. Difficile tenere alta la tensione nelle varie serie?
«Sono convinta che le serie tv ambientate in ospedale abbiano grande successo perché si muovono sempre sulla dualità vita/morte e per tale motivo tutti i personaggi guardano la vita in modo diverso, più profondo. Il rapporto con House è ricco di problemi e alti e bassi, certo, ma è una relazione coraggiosa che ha dato una svolta alla serie».
E il tuo rapporto personale con Hugh Laurie?
«Ci rispettiamo molto e questo permette di recitare e stare sul set in modo naturale. Hugh sostiene molto non solo me ma l’intero cast e l’ho sempre sentito dalla mia parte».
Ma perché sei uscita da Dr.House? Anche la serie ne ha risentito…
«E’ stata una scelta necessaria, personale, dolorosa anche. La vita e il lavoro non dovrebbero incrociarsi e quando accade…bisogna agire subito».
I protagonisti delle serie tv pluri-stagionali rischiano di venire identificati con il proprio alter-ego sullo schermo. Accade lo stesso per te?
«Non credo sia affatto un problema ma so che per alcuni è così. Dopo Dr. House ho recitato in The Good Wife ed è stato fantastico e ora sto anche scrivendo un pilot per la tv ma chissà se si realizzerà».
Sei molto impegnata a livello civile per diverse cause come l’aborto e i diritti delle donne. La FOX ti ha mai ostacolata?
«Assolutamente. La FOX è di destra ed è cosa risaputa ma mi hanno sempre lasciata libera di svolgere le mie campagne mediatiche in favore dell’aborto, dei diritti per le donne, dei gay e dei transgender. Un microfono acceso, oggi, dà incredibili opportunità di diffondere un messaggio e questa potenza mediatica credo che debba essere utilizzata nel miglior modo possibile».
Infine una curiosità: il tuo sorrisetto laterale è ormai celebre. Ti sei allenata a lungo?
«No (ride) è totalmente naturale!»
Francesco Musolino