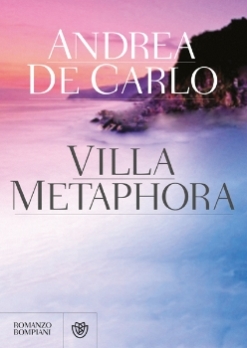Vicentino, chef stellato Michelin e uno sguardo che sa ammaliare ma che fa anche paura: il nuovo sex symbol del mondo tv si chiama Carlo Cracco. A soli quattordici anni è entrato in cucina, apprendendo l’arte culinaria dai più grandi – da Gualtiero Marchesi ad Alain Ducasse – e dal 2007 il suo omonimo ristorante nel centro di Milano (che ha assorbito lo storico marchio Peck) figura nella top50 mondiale. Accanto a Guido Barbieri, chef pluristellato, e l’imprenditore Joe Bastianich, bandiera della ristorazione italiana nel mondo, completa il terribile trio di giudici di Masterchef, il talent show in onda su Sky per la seconda stagione che ha conquistato pubblico e critica grazie ad un linguaggio televisivo finalmente dinamico e aggressivo, lontano anni luce dalle altre trasmissioni televisive che intasano i palinsesti televisivi.
Vicentino, chef stellato Michelin e uno sguardo che sa ammaliare ma che fa anche paura: il nuovo sex symbol del mondo tv si chiama Carlo Cracco. A soli quattordici anni è entrato in cucina, apprendendo l’arte culinaria dai più grandi – da Gualtiero Marchesi ad Alain Ducasse – e dal 2007 il suo omonimo ristorante nel centro di Milano (che ha assorbito lo storico marchio Peck) figura nella top50 mondiale. Accanto a Guido Barbieri, chef pluristellato, e l’imprenditore Joe Bastianich, bandiera della ristorazione italiana nel mondo, completa il terribile trio di giudici di Masterchef, il talent show in onda su Sky per la seconda stagione che ha conquistato pubblico e critica grazie ad un linguaggio televisivo finalmente dinamico e aggressivo, lontano anni luce dalle altre trasmissioni televisive che intasano i palinsesti televisivi.
Ho raggiunto telefonicamente lo chef Cracco nella “sua” Milano, occasione perfetta per discutere di gusto e coraggio ai fornelli e parlare del suo ultimo libro, “Se vuoi fare il figo usa lo scalogno – Dalla pratica alla grammatica: imparare a cucinare in 60 ricette” (Rizzoli, pp. 252, euro 15,90).
Chef Cracco, perché ha scelto di stare dietro i fornelli?
«La scelta della cucina è stata progressiva. Inizialmente mi tentava l’idea di fare il barista o il pasticciere, ma dovendo recuperare ad una grave insufficienza alla scuola alberghiera, mi hanno mandato a lavorare per capire se fossi o meno, tagliato per la professione. Appena sono entrato in cucina, a quattordici anni, mi si è aperto un mondo».
Quentin Tarantino ha recentemente dichiarato che più si ha talento, più bisogna rischiare. In cucina quanto si può osare?
«In cucina non bisogna osare ma si deve essere disposti a rischiare molto, però bisogna anche capire quando si è arrivati al punto limite. Fare lo chef significa comprendere che non si cucina per se stessi ma per i clienti, per cui ogni piatto deve essere comprensibile a tutti».
Ha dichiarato che in futuro mangeremo sempre di più gli insetti. Quanto c’è di vero e quanto di provocatorio?
«Nel mondo ci sono oltre trenta Paesi i cui abitanti assumono le proteine in questo modo e l’allevamento di insetti non inquina nulla se paragonato a quello di manzi o maiali. Certamente fa molto effetto ma è tutta una questione culturale. Però non li metterei mai sul mio menù…».
È d’accordo se le dico che il suo libro, “Se vuoi fare il figo usa lo scalogno”, è molto diverso dagli standard dei libri di cucina?
«Sì. Volevo fosse fresco, veloce e comprensibile ma soprattutto doveva raggiungere il suo scopo, far imparare a cucinare. Per questo cerco di immedesimarmi con chi è a casa e con le possibili difficoltà, proponendo varie soluzioni per fare il piatto con successo».
Lei chiede di mettere da parte surgelati e cibi in scatola…
«Non attacco il cibo spazzatura ma mangiare fresco fa davvero bene, ci mette in contatto con sostanze vive e costa decisamente meno. Comprare pietanze pronte va bene, l’importante è che non diventi la regola».
 Il format Masterchef nacque nel 1990 ma da noi è giunto solo l’anno scorso. Solo adesso l’italiano è pronto a mettere in discussione la cucina della mamma?
Il format Masterchef nacque nel 1990 ma da noi è giunto solo l’anno scorso. Solo adesso l’italiano è pronto a mettere in discussione la cucina della mamma?
«La cucina della mamma non si discute, anzi, si rivaluta. In trasmissione le più brave sono proprio le donne perché hanno manualità e vera passione mentre il maschio lo fa più per vantarsi, perché fa figo, non è mai una necessità. La cucina della mamma è la nostra salvezza ma non è detto che si debba mangiare solo quello».
Il successo di Masterchef deriva dal taglio professionale con cui è costruito?
«Certamente. Accusano spesso me, Guido e Joe di essere troppo cattivi, troppo severi. Forse siamo un po’ duri ma solo perché vogliamo che ci sia serietà e rispetto per questo mestiere. Un talent televisivo non deve essere per forza volgare o stupido e Masterchef è l’unico programma in cui si cucina davvero, in cui si segue la nascita e lo sviluppo del piatto. Il resto son tutti surrogati».
C’è più invidia nel mondo dell’alta cucina o in tv?
«L’invidia è uguale, ahimé. Purtroppo fa parte dell’essere umano. Talvolta, però, può anche fare bene perché ti permette di fare il salto necessario».
C’è una portata cui non rinuncerebbe mai?
«La pasta, senza dubbio. La settimana scorsa ero all’estero e cercavo di spiegare come da noi sia un piatto importante che non sostituisce il secondo di carne o pesce, che non è un contorno o un antipasto. La pasta è alla base della nostra cucina perché dentro c’è tutto. Pensate alla lasagna: dentro troviamo la salsa besciamella, la pasta, il ragù, il pomodoro e le verdure. Un piatto unico e dopo sei sazio».
«Significa capire ciò che sto mangiando».
Perché annusa sempre prima di assaggiare?
«Perché il naso è la prima forma di riconoscimento e non può essere illuso dalla bellezza, come accade agli occhi».
Il suo sguardo di ghiaccio è ormai celebre. Dica la verità, lo prova allo specchio?
«Noo (ride). Lo faccio per mettere in difficoltà, per entrare in contatto con i concorrenti eliminando i filtri. Ma se capisco che recitano… vado giù duro».
In futuro cosa farà, si dedicherà al viaggio, la sua vera passione?
«Sogni ce ne son sempre tanti. Uno di questi è lavorare un po’ di meno».
Questo è molto poco milanese, però!
«Lo so. Ma spesso i milanesi esagerano e perdono di vista alcuni dettagli importanti».
©Intervista pubblicata sul quotidiano La Gazzetta del Sud
Francesco Musolino®