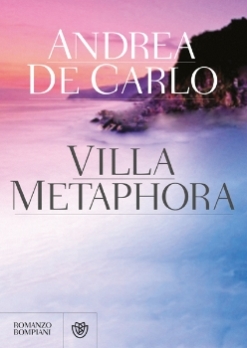Che fine ha fatto Nola Kellergan? Chi ha ucciso la quindicenne d’America? Eccezion fatta per l’“Inferno” di Dan Brown, il libro del momento è senza dubbio “La verità sul caso Harry Quebert” e pensare che il suo autore, il 27enne ginevrino Jöel Dicker, si era concesso un altro tentativo con la scrittura prima di cambiare strada. E invece il suo libro ha da poco sforato il milione di copie vendute – già premiato con il prestigioso Grand Prix du roman de l’Académie Francaise e in corso di traduzione in 25 paesi – in Italia è edito da Bompiani che punta forte su questo libro ambientato nella provincia americana con un esordio che rievoca le atmosfere di Truman Capote in “A sangue freddo”. Ma il suo vero punto di forza è uno stile narrativo simile a quello di una serie-tv americana di successo, capace di mescolare atmosfere thriller, dialoghi reali e una buona dose di humour pungente. Il protagonista del libro, il talentuoso scrittore di successo Marcus Goldman, afflitto dal blocco della pagina bianca, decide di tornare dal suo maestro, il romanziere di successo Harry Quebert ma ben presto si troverà invischiato in un’indagine di omicidio in cui l’unico indiziato della morte della giovane Nola sarà proprio l’amico Harry. Una storia d’amore proibita, un editore senza scrupoli, un mucchio di segreti inconfessabili ma impossibili da proteggere sono gli ingredienti di una storia sempre in bilico fra verità e menzogna, in cui nulla è come sembra.
Che fine ha fatto Nola Kellergan? Chi ha ucciso la quindicenne d’America? Eccezion fatta per l’“Inferno” di Dan Brown, il libro del momento è senza dubbio “La verità sul caso Harry Quebert” e pensare che il suo autore, il 27enne ginevrino Jöel Dicker, si era concesso un altro tentativo con la scrittura prima di cambiare strada. E invece il suo libro ha da poco sforato il milione di copie vendute – già premiato con il prestigioso Grand Prix du roman de l’Académie Francaise e in corso di traduzione in 25 paesi – in Italia è edito da Bompiani che punta forte su questo libro ambientato nella provincia americana con un esordio che rievoca le atmosfere di Truman Capote in “A sangue freddo”. Ma il suo vero punto di forza è uno stile narrativo simile a quello di una serie-tv americana di successo, capace di mescolare atmosfere thriller, dialoghi reali e una buona dose di humour pungente. Il protagonista del libro, il talentuoso scrittore di successo Marcus Goldman, afflitto dal blocco della pagina bianca, decide di tornare dal suo maestro, il romanziere di successo Harry Quebert ma ben presto si troverà invischiato in un’indagine di omicidio in cui l’unico indiziato della morte della giovane Nola sarà proprio l’amico Harry. Una storia d’amore proibita, un editore senza scrupoli, un mucchio di segreti inconfessabili ma impossibili da proteggere sono gli ingredienti di una storia sempre in bilico fra verità e menzogna, in cui nulla è come sembra.
Il suo libro è il caso letterario del momento. E’ vero che aveva intenzione di smettere?
«Questo è il mio sesto romanzo. I precedenti cinque erano stati tutti rifiutati per cui, quando ho cominciato a scriverlo, ho semplicemente pensato che se anche questo sarebbe stato rifiutato avrei cercato altrove la mia strada».
Si muove di continuo fra verità e menzogna, in un gioco degli specchi ma com’è nata l’idea del libro?
«Ho cominciato a scrivere con l’idea di parlare del New Hampshire e da lì ho iniziato ad immaginare il rapporto fra Marcus e Harry che, evolvendosi, mi ha spinto a chiedermi cosa fossero verità e menzogna, in che rapporto si muovessero. Ma non avevo nessuna idea precostituita a riguardo. Mi sono messo a scrivere e in questo senso ogni giorno era una scoperta».
Il rapporto fra maestro e allievo si esplica in delle significative lezioni di scrittura che aprono ciascun capitolo. Come sono nate?
«Viene tutto dalla mia fantasia. Un libro che parla di un altro libro mi permetteva di inserire dei consigli di scrittura; in tal modo potevo definire meglio il rapporto fra Harry e Marcus e al tempo stesso introdurre il capitolo».
Va giù duro con Barnasky facendogli incarnare l’editore pronto a tutto pur di incassare profitto e produrre utili.
«Volevo mettere sotto la lente d’ingrandimento il mondo delle aziende e criticare quegli imprenditori, grandi o piccoli non importa, completamente prigionieri di una spirale in cui contano solo il bilancio, gli utili e la spasmodica ricerca del profitto. Al punto che non importa cosa producono, l’importante è che li faccia guadagnare».
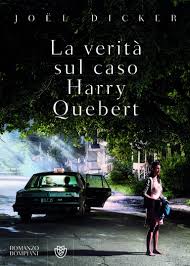 Scrive che “La malattia degli scrittori è non voler più scrivere senza riuscire a farlo”. Pensa che Philip Roth riuscirà a smettere?
Scrive che “La malattia degli scrittori è non voler più scrivere senza riuscire a farlo”. Pensa che Philip Roth riuscirà a smettere?
«Conosco la sua storia e il suo proposito ma non sappiamo se ha smesso davvero di scrivere. Voglio dire, magari non pubblicherà più nulla di nuovo e il suo lavoro non sarà più accessibile al pubblico ma è cosa ben diversa dal riuscire a smettere tout court».
In linea con i grandi maestri della letteratura americana come Ernst Hemingway e Jack London, ha associato la scrittura al pugilato. Cosa hanno in comune?
«Si tratta in entrambi i casi di una dura lotta contro se stessi, una battaglia personale, esclusivamente personale, che ha senso solo per chi la compie. Guardando il pugilato ci si può domandare che senso abbia farsi prendere a pugni in faccia ma per il pugile il combattimento ha un senso profondo. Per la scrittura vale il medesimo discorso. Ad un certo punto ti chiedi se il libro piacerà o meno ma la cosa più importante è mettersi alla prova e lottare contro se stessi».
Per Mallarmé tutto il mondo è fatto per finire in un bel libro e lei fa dire ad Harry che solo la scrittura può donare senso alla vita stessa. Per lei la scrittura e la vita in che rapporto sono?
«Per Marcus e Harry solo la scrittura può donare senso al caos delle loro vite ma non è così per tutti chiaramente. Per quanto mi riguarda, io scrivo per realizzare me stesso, per cercare di superarmi e trascendermi. Oggi viviamo in un mondo allarmante e allarmista in cui manca del tutto la proiezione del futuro per la nostra generazione. Ai nostri genitori dicevano di guardare con speranza nei tempi a venire ma noi proprio non possiamo permettercelo e proprio per questo io intendo scrivere. Per lasciare qualcosa di me».
Lei come se lo immagina il paradiso degli scrittori?
«Bella domanda (ride). Lì tutto è possibile, proprio per questo è il Paradiso».
Francesco Musolino®
Fonte: La Gazzetta del Sud