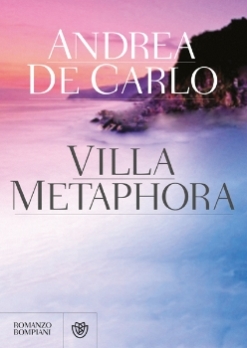Archivi Blog
Jöel Dicker: «Nel Paradiso degli scrittori tutto è possibile»
 Che fine ha fatto Nola Kellergan? Chi ha ucciso la quindicenne d’America? Eccezion fatta per l’“Inferno” di Dan Brown, il libro del momento è senza dubbio “La verità sul caso Harry Quebert” e pensare che il suo autore, il 27enne ginevrino Jöel Dicker, si era concesso un altro tentativo con la scrittura prima di cambiare strada. E invece il suo libro ha da poco sforato il milione di copie vendute – già premiato con il prestigioso Grand Prix du roman de l’Académie Francaise e in corso di traduzione in 25 paesi – in Italia è edito da Bompiani che punta forte su questo libro ambientato nella provincia americana con un esordio che rievoca le atmosfere di Truman Capote in “A sangue freddo”. Ma il suo vero punto di forza è uno stile narrativo simile a quello di una serie-tv americana di successo, capace di mescolare atmosfere thriller, dialoghi reali e una buona dose di humour pungente. Il protagonista del libro, il talentuoso scrittore di successo Marcus Goldman, afflitto dal blocco della pagina bianca, decide di tornare dal suo maestro, il romanziere di successo Harry Quebert ma ben presto si troverà invischiato in un’indagine di omicidio in cui l’unico indiziato della morte della giovane Nola sarà proprio l’amico Harry. Una storia d’amore proibita, un editore senza scrupoli, un mucchio di segreti inconfessabili ma impossibili da proteggere sono gli ingredienti di una storia sempre in bilico fra verità e menzogna, in cui nulla è come sembra.
Che fine ha fatto Nola Kellergan? Chi ha ucciso la quindicenne d’America? Eccezion fatta per l’“Inferno” di Dan Brown, il libro del momento è senza dubbio “La verità sul caso Harry Quebert” e pensare che il suo autore, il 27enne ginevrino Jöel Dicker, si era concesso un altro tentativo con la scrittura prima di cambiare strada. E invece il suo libro ha da poco sforato il milione di copie vendute – già premiato con il prestigioso Grand Prix du roman de l’Académie Francaise e in corso di traduzione in 25 paesi – in Italia è edito da Bompiani che punta forte su questo libro ambientato nella provincia americana con un esordio che rievoca le atmosfere di Truman Capote in “A sangue freddo”. Ma il suo vero punto di forza è uno stile narrativo simile a quello di una serie-tv americana di successo, capace di mescolare atmosfere thriller, dialoghi reali e una buona dose di humour pungente. Il protagonista del libro, il talentuoso scrittore di successo Marcus Goldman, afflitto dal blocco della pagina bianca, decide di tornare dal suo maestro, il romanziere di successo Harry Quebert ma ben presto si troverà invischiato in un’indagine di omicidio in cui l’unico indiziato della morte della giovane Nola sarà proprio l’amico Harry. Una storia d’amore proibita, un editore senza scrupoli, un mucchio di segreti inconfessabili ma impossibili da proteggere sono gli ingredienti di una storia sempre in bilico fra verità e menzogna, in cui nulla è come sembra.
Il suo libro è il caso letterario del momento. E’ vero che aveva intenzione di smettere?
«Questo è il mio sesto romanzo. I precedenti cinque erano stati tutti rifiutati per cui, quando ho cominciato a scriverlo, ho semplicemente pensato che se anche questo sarebbe stato rifiutato avrei cercato altrove la mia strada».
Si muove di continuo fra verità e menzogna, in un gioco degli specchi ma com’è nata l’idea del libro?
«Ho cominciato a scrivere con l’idea di parlare del New Hampshire e da lì ho iniziato ad immaginare il rapporto fra Marcus e Harry che, evolvendosi, mi ha spinto a chiedermi cosa fossero verità e menzogna, in che rapporto si muovessero. Ma non avevo nessuna idea precostituita a riguardo. Mi sono messo a scrivere e in questo senso ogni giorno era una scoperta».
Il rapporto fra maestro e allievo si esplica in delle significative lezioni di scrittura che aprono ciascun capitolo. Come sono nate?
«Viene tutto dalla mia fantasia. Un libro che parla di un altro libro mi permetteva di inserire dei consigli di scrittura; in tal modo potevo definire meglio il rapporto fra Harry e Marcus e al tempo stesso introdurre il capitolo».
Va giù duro con Barnasky facendogli incarnare l’editore pronto a tutto pur di incassare profitto e produrre utili.
«Volevo mettere sotto la lente d’ingrandimento il mondo delle aziende e criticare quegli imprenditori, grandi o piccoli non importa, completamente prigionieri di una spirale in cui contano solo il bilancio, gli utili e la spasmodica ricerca del profitto. Al punto che non importa cosa producono, l’importante è che li faccia guadagnare».
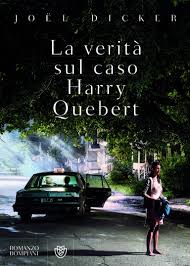 Scrive che “La malattia degli scrittori è non voler più scrivere senza riuscire a farlo”. Pensa che Philip Roth riuscirà a smettere?
Scrive che “La malattia degli scrittori è non voler più scrivere senza riuscire a farlo”. Pensa che Philip Roth riuscirà a smettere?
«Conosco la sua storia e il suo proposito ma non sappiamo se ha smesso davvero di scrivere. Voglio dire, magari non pubblicherà più nulla di nuovo e il suo lavoro non sarà più accessibile al pubblico ma è cosa ben diversa dal riuscire a smettere tout court».
In linea con i grandi maestri della letteratura americana come Ernst Hemingway e Jack London, ha associato la scrittura al pugilato. Cosa hanno in comune?
«Si tratta in entrambi i casi di una dura lotta contro se stessi, una battaglia personale, esclusivamente personale, che ha senso solo per chi la compie. Guardando il pugilato ci si può domandare che senso abbia farsi prendere a pugni in faccia ma per il pugile il combattimento ha un senso profondo. Per la scrittura vale il medesimo discorso. Ad un certo punto ti chiedi se il libro piacerà o meno ma la cosa più importante è mettersi alla prova e lottare contro se stessi».
Per Mallarmé tutto il mondo è fatto per finire in un bel libro e lei fa dire ad Harry che solo la scrittura può donare senso alla vita stessa. Per lei la scrittura e la vita in che rapporto sono?
«Per Marcus e Harry solo la scrittura può donare senso al caos delle loro vite ma non è così per tutti chiaramente. Per quanto mi riguarda, io scrivo per realizzare me stesso, per cercare di superarmi e trascendermi. Oggi viviamo in un mondo allarmante e allarmista in cui manca del tutto la proiezione del futuro per la nostra generazione. Ai nostri genitori dicevano di guardare con speranza nei tempi a venire ma noi proprio non possiamo permettercelo e proprio per questo io intendo scrivere. Per lasciare qualcosa di me».
Lei come se lo immagina il paradiso degli scrittori?
«Bella domanda (ride). Lì tutto è possibile, proprio per questo è il Paradiso».
Francesco Musolino®
Fonte: La Gazzetta del Sud
Patrick McGrath: «In tutti noi c’è un pizzico di follia»
 Dopo aver presentato in anteprima mondiale al Salone del Libro di Torino il suo ultimo libro, “L’Estranea” (Bompiani, pp. 292 euro 18,50), il noto scrittore inglese Patrick McGrath – autore del best-seller “Follia” – è tornato in Italia in occasione della Milanesiana, intervenendo sul tema della perfezione. McGrath è ormai celebre per la sua capacità di indagare la mente dei propri protagonisti, creando un clima di suspense che difficilmente concede scampo al lettore, posto al centro delle emozioni narrate. La sua nuova protagonista, Constance, è una donna infelice che si rifugia in un frettoloso matrimonio, ma ben presto si renderà conto che aver sposato Sidney, un uomo ben più maturo, è soltanto un altro passo verso la ricerca di una figura paterna. Sul piatto della bilancia narrativa, McGrath aggiunge anche i sentimenti contrastanti che la protagonista prova per l’esuberante sorella minore, Iris, sua nemesi e detentrice di una sconvolgente verità che condurrà Constance verso il baratro della follia.
Dopo aver presentato in anteprima mondiale al Salone del Libro di Torino il suo ultimo libro, “L’Estranea” (Bompiani, pp. 292 euro 18,50), il noto scrittore inglese Patrick McGrath – autore del best-seller “Follia” – è tornato in Italia in occasione della Milanesiana, intervenendo sul tema della perfezione. McGrath è ormai celebre per la sua capacità di indagare la mente dei propri protagonisti, creando un clima di suspense che difficilmente concede scampo al lettore, posto al centro delle emozioni narrate. La sua nuova protagonista, Constance, è una donna infelice che si rifugia in un frettoloso matrimonio, ma ben presto si renderà conto che aver sposato Sidney, un uomo ben più maturo, è soltanto un altro passo verso la ricerca di una figura paterna. Sul piatto della bilancia narrativa, McGrath aggiunge anche i sentimenti contrastanti che la protagonista prova per l’esuberante sorella minore, Iris, sua nemesi e detentrice di una sconvolgente verità che condurrà Constance verso il baratro della follia.
Al Salone del Libro di Torino lei ha dichiarato che preferisce portare in pagina donne problematiche. Perché ha scelto Constance come protagonista de “L’Estranea”?
«Constance è nata dal desiderio di porre al centro del libro una donna che avesse dei rapporti problematici con il padre, proprio per tale motivo lei deciderà di sposare un uomo più maturo che vedrà come una figura paterna. Ma queste scelte comporteranno delle inevitabili conseguenze».
A differenza di altre sue protagoniste, Constance sembra in preda a passioni e sentimenti imperscrutabili. Dal punto di vista narrativo è stata una sfida gestire questo personaggio?
«Assolutamente. Constance è stato il personaggio più complesso e problematico che abbia mai creato, ho avuto davvero grosse difficoltà a capirla. Mi sono serviti quattro anni per scrivere questo libro, un tempo necessario per comprendere la vera natura della mia protagonista, il senso delle sue azioni».
Sin dalla prima pagina si ha l’impressione che Constance possa fare qualcosa di irrimediabile da un momento all’altro, quasi come se lei la rincorresse sulla pagina…
«Sono d’accordo. Questa perdita di controllo sulla mia protagonista è stata proficua per il ritmo e la profondità del libro ma è stata anche un’esperienza molto dolorosa, a volte. Non ero certo che sarei riuscito a terminare il libro, né se sarei stato in grado di trasmettere al lettore il fascino che Constance esercitava su me».
In generale lei sembra avere una netta preferenza per le protagoniste femminili. Trova più interessante l’universo femminile?
«Sin dall’inizio della mia carriera di scrittore mi sono reso conto che i problemi maschili mi annoiavano. Al contrario le problematiche del mondo femminile mi hanno sempre attratto, soprattutto quelle derivanti dal fardello aggiuntivo di dover interagire con gli uomini».
Per la prima volta ha deciso di scegliere un punto di vista alternato fra Constance e Sidney. Perché?
«Volevo mostrare come Constance leggesse la realtà, permettendoci di provare empatia per lei e per il suo modo di vedere le cose. Contemporaneamente volevo mostrare come quella stessa realtà apparisse agli occhi di un’altra persona, affinché il lettore potesse provare sensazioni e stati d’animo differenti, pur se derivanti dai medesimi eventi».
La sua fama è certamente legata alla grande capacità di leggere i processi logici e illogici dei suoi personaggi. Com’è nata questa particolare passione?
«Il mio grande interesse per la natura umana e le emozioni talvolta laceranti che siamo capaci di provare, li devo a mio padre che ha certamente avuto una fortissima influenza su di me. Proprio grazie a lui (ha lavorato a lungo nel manicomio criminale di Broadmoor come psicologo, ndr) mi sono interessato alla letteratura psicologia e alle opere di psichiatria, soprattutto quella di Freud. Da romanziere ciò ha comportato un particolare interesse per la vita interiore delle persone, per il loro modo di leggere la realtà e l’interazione con gli altri.
Lei scrive “credo che ciascuno di noi si crei il proprio destino, scegliendo se restare vittima o no, della propria infanzia”. Cosa ne direbbe Freud?
«Freud non avrebbe avuto problemi con quest’affermazione, non era un determinista e dunque non credeva che noi fossimo destinati ad esprimere nella nostra vita le nevrosi trasmesse dai nostri genitori. Nondimeno certamente suggerirebbe di ricorrere alla psicanalisi per affrontare il bagaglio emotivo ma io sono convinto che non si debba necessariamente ricorrere ad uno specialista per risolvere i nostri problemi, anzi, credo che ci si possa curare da soli».
Non crede che un pizzico di follia serva a raggiungere la felicità?
«Certo. Ci sono tracce di pazzia nei nostri gusti musicali, nel nostro abbigliamento, nel senso dell’umorismo, nella fantasia e nel modo in cui si esprimiamo al di fuori del contesto lavorativo. Senza dubbio c’è un pizzico di pazzia anche nei nomi che diamo ai nostri figli».
Francesco Musolino®
Fonte: La Gazzetta del Sud
La Carta e il Territorio. Un romanzo ditirambico
 Se non avesse ancora scritto Piattaforma, l’ultimo romanzo dello scrittore francese Michel Houellebecq, La Carta e il Territorio (Bompiani, traduz. it. di Fabrizio Ascari, pp. 364; €20) sarebbe la sua miglior prova. Perché? Appena lo si comincia a leggere si ha l’impressione che si debba necessariamente rallentare l’impeto volontario della lettura, centellinando le pagine quasi come si stesse sorseggiando un pregiato vino. Se esisteva ancora al giorno d’oggi la possibilità di scrivere un romanzo totale, Houellebecq l’ha colta e fatta sua e il tanto atteso trionfo al premio Goncourt – posta l’ostilità assai nota dei critici nei suoi confronti – lo avvalora ancor di più.
Se non avesse ancora scritto Piattaforma, l’ultimo romanzo dello scrittore francese Michel Houellebecq, La Carta e il Territorio (Bompiani, traduz. it. di Fabrizio Ascari, pp. 364; €20) sarebbe la sua miglior prova. Perché? Appena lo si comincia a leggere si ha l’impressione che si debba necessariamente rallentare l’impeto volontario della lettura, centellinando le pagine quasi come si stesse sorseggiando un pregiato vino. Se esisteva ancora al giorno d’oggi la possibilità di scrivere un romanzo totale, Houellebecq l’ha colta e fatta sua e il tanto atteso trionfo al premio Goncourt – posta l’ostilità assai nota dei critici nei suoi confronti – lo avvalora ancor di più.
Come accadeva nel già citato Piattaforma o ne La possibilità di un’isola, Houellebecq non ha timore di osare. Chi ha letto Nemici Pubblici ovvero una serie di dialoghi con il controverso filosofo Bernard-Henri Lévy, sa bene che non si tratta affatto di divismo o uno snobismo asservito al mercato editoriale; al contrario l’autore da sempre sembra curarsi assai poco degli intermediari avendo sempre preferito parlare direttamente ai lettori. Ma non essendo un mero dispensatore di banalità, non è amato da tutti. Anzi spesso viene considerato soltanto un provocatore. Ne La Carta e il Territorio lo scrittore transalpino porta sulla pagina una serie di personaggi assai noti, fra cui scrittori e giornalisti. Una lunga serie su cui spiccano la sua editrice Teresa Cremisi e lo scrittore Frédéric Beigbeder ma soprattutto se stesso, Michel Houellebecq. Il libro si apre con le paturnie del talentuoso artista Jed Martin che sta per allestire la sua seconda personale ma perché il pubblico comprenda la sua decisione di passare dalla fotografia – la sua prima passione che ne ha decretato il successo immediato – alla pittura, serve un testo critico di grande impatto mediatico. Chi meglio di Michel Houellebecq? Nonostante la sua nota fama di misantropo – l’autore non si descrive mai con l’aureola del santo, forse talvolta dell’incompreso – il suo gallerista lo convince che sia necessario insistere. E ha ragione.L’autore con un agile passo indietro ci racconta che Jed era un adolescente anomalo, «mentre i suoi coetanei ne sapevano di solito un po’ di più sulla vita di Spiderman che su quella di Gesù», lui aveva letto con ordine e disciplina tutti i classici. Prima di arrivare alla pittura, un lungo flashback ci racconta che il suo rapporto con l’arte sbocciò grazie alla fotografia ma Martin sarà destinato a passare da una passione all’altra sacrificando tutto in nome dell’ispirazione perché – e qui ritroviamo lo stesso credo dello scrittore – è necessario tenere sempre i sensi all’erta: «la vita serve le carte ma poi è lesta a riprendersele» se le occasioni non le si sfrutta a tempo debito.Grazie alla fotografia Jed Martin sbanca e conosce anche la russa Olga. Fra i due, lui piccolo e gracile, lei vertiginosamente bella, scoppia una passione ardente. Lei per la prima volta le apre le porte del mondo dell’arte e lui, ancora spaesato fra cocktail e vernissage, si sentirà spesso come uno di quei giovinetti amanti di donne importanti. Quasi come uno dei giovani amanti creati dalla penna di Colette. Ma i loro destino è segnato perché lui resterà sempre «un piccolo francese indeciso». L’entrata in scena di Houellebecq condurrà, come anticipato, Martin alla ricchezza e al successo definitivo e persino il tormentato scrittore – che sembrava destinato a vivere per sempre in una casa piena di scatoloni, isolato da tutto e in una Francia del futuro ritornata felicemente all’agricoltura dopo il definitivo crollo del sistema capitalistico mondiale – troverà la serenità ritornando nella sua casa dell’infanzia, in un minuscolo borgo. Ma ecco che Houellebecq vira bruscamente mettendo in scena il suo stesso, brutale, omicidio.La seconda parte del romanzo, che sarà incentrata sulle indagini relative all’assassinio dello scrittore e del suo cane, vedrà come protagonista Jasselin, un poliziotto esperto e ad un passo dalla pensione. Un uomo ormai capace di accettare la brutalità del mondo ma, come sottolinea in un bel dialogo con la moglie, esausto nello scovare dietro ogni delitto un movente assolutamente razionale, spesso meramente economico.
 La Carta e il Territorio colpisce perché è un romanzo scritto con grande padronanza del flusso narrativo. Houellebecq controlla sul velluto i rimandi al passato e il difficoltoso rapporto fra Jed e suo padre, avendo modo anche di attaccare tanto il sistema economico attuale che il politically correct oggi imperante. La svolta thriller che gli permette di portare sulla pagina la propria morte è un tocco di classe e sfrontatezza che sottolinea la maturità raggiunta da Houellebecq tanto da avergli permesso di conquistare, finalmente, il premio Goncourt.
La Carta e il Territorio colpisce perché è un romanzo scritto con grande padronanza del flusso narrativo. Houellebecq controlla sul velluto i rimandi al passato e il difficoltoso rapporto fra Jed e suo padre, avendo modo anche di attaccare tanto il sistema economico attuale che il politically correct oggi imperante. La svolta thriller che gli permette di portare sulla pagina la propria morte è un tocco di classe e sfrontatezza che sottolinea la maturità raggiunta da Houellebecq tanto da avergli permesso di conquistare, finalmente, il premio Goncourt.
Patrizia Wächter: «Vi racconto chi era Papà Leo»
 Leggendo le belle e accorate pagine di “Papà Leo” (Bompiani editore, pp. 204, €16,50) riviviamo l’incredibile vita dell’impresario Leo Wächter guidati dalla prosa semplice e piacevole della figlia Patrizia, che per quindici anni ha gestito con lui il “mitico” Teatro Ciak di Via San Gallo n°33, a Milano. Oggi Patrizia è un’affermata figura nel mondo cinematografico, collabora con diversi registi sia italiani che stranieri e tra gli altri, con il Noir in Festival, il Festival del film di Locarno, le Giornate degli autori a Venezia, il Torino Film Festival.
Leggendo le belle e accorate pagine di “Papà Leo” (Bompiani editore, pp. 204, €16,50) riviviamo l’incredibile vita dell’impresario Leo Wächter guidati dalla prosa semplice e piacevole della figlia Patrizia, che per quindici anni ha gestito con lui il “mitico” Teatro Ciak di Via San Gallo n°33, a Milano. Oggi Patrizia è un’affermata figura nel mondo cinematografico, collabora con diversi registi sia italiani che stranieri e tra gli altri, con il Noir in Festival, il Festival del film di Locarno, le Giornate degli autori a Venezia, il Torino Film Festival.
A dieci anni di distanza dalla morte del padre, Patrizia Wächter ha deciso di farne rivivere la figura e con essa il suo coraggio, il grande intuito e la sua famosa generosità. Leo Wächter, ancora bambino, finì nel campo di lavoro di Dachau dal quale fuggì finendo in Olanda, poi in Jugoslavia e infine in Italia ma solo nel 1966 ottenne la cittadinanza e ciò lo costrinse a rinunciare a due sogni. Partecipò alla Resistenza, finì in carcere e conobbe la famiglia Fo.
I suoi risultati come impresario privato sono incredibili: fu lui a organizzare la storica tournée dei Beatles nel giugno 1965. Oltre ai Beatles, portò nel nostro paese artisti del calibro di Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, The Who, il grande Frank Sinatra, senza dimenticare la sua grande passione per il mondo circense e l’avventura della balena Jonas…
Patrizia, come mai ha voluto raccontare la vita di suo padre a dieci anni dalla sua scomparsa?
Alla base di questa scelta ci sono una serie di motivi. Innanzitutto per elaborare i lutti serve parecchio tempo ma anche perché, col passare degli anni, le persone che ricordavano il suo impegno e i suoi successi erano sempre meno. Quando morì non organizzammo nulla e non partecipammo a nessuna commemorazione in suo nome ma non vi fu alcuna decisione alla base, era semplicemente la nostra risposta, il nostro modo di sopravvivere alla sua scomparsa. Però mi dispiaceva tantissimo rendermi conto che quando si parlava di jazz, di circo, di teatro o di rock, quasi nessuno lo citava. Scriverlo è stato molto duro: è servito oltre un anno di ricerche per reperire il materiale e per me, che odio scrivere persino i comunicati stampa, mettermi alla prova con un romanzo è stato come entrare in terapia. Delle ricerche si sono occupati Leonard e mio marito Antonello che hanno ricostruito tutto con grande cura anche grazie a delle associazioni polacche che hanno permesso di ricostruire la prima parte della sua vita. Anche Umberto Veronesi e Dario Fo mi hanno aiutato a ricostruire degli aspetti della sua vita che non potevo conoscere, come la sua militanza partigiana che la sorella di Dario, Bianca, ricostruisce in parte nel suo libro Io, da grande, mi sposo un partigiano. La ringhiera dei miei vent’anni (Einaudi).
Per via del suo vissuto ma anche del suo attuale lavoro sottolinea senza snobismo che la fascinazione per la celebrità non l’hai mai davvero vissuta. Forse l’unica volta fu in quella foto accanto ai Fab Four…
Beh, l’emozione di aver conosciuto i Beatles venne anni dopo. Ero una persona talmente fortunata che anche quella tournée mi sembrava normale. Credo ci siano due tipi di emozioni quando si conoscono personaggi davvero importanti, quella artistica e quella da autografo. Quest’ultima, davvero, non l’ho mai provata ma quella artistica la provo ancora oggi. La storia della foto è davvero particolare perché, all’improvviso mi hanno seduta accanto a loro e quella foto, mi è giunta anni dopo dalla famiglia di mio padre che vive in America. Invece la foto in cui sono immortalata mentre scendo dall’aereo con i Beatles l’ha trovata casualmente mio marito Antonello in una libreria. Pensate che io non sapevo nemmeno che esistesse quella foto.
Però Antonello lei non lo faceva nemmeno entrare al Derby…
Allora ero una ragazzina un poco viziata e al Derby facevo entrare solo i miei amici. E lui non lo era!
Nel libro riporta il contratto coi Beatles: era un semplice foglio di carta con quattro righe e due firme in calce, quasi un gentleman agreement. Che differenza con i contratti di oggi…
Mio padre aveva amici sparsi per il mondo che gli mandavano telegrammi con poche righe. In quello dei Rolling Stones, dietro, ci sono solo le date di nascita. Oggi è cambiato tutto. Basta pensare ai miei contratti o quelli con i festival, roba di pagine su pagine. Oppure, quando curo un grosso film a livello nazionale, arrivano dagli uffici stampa una serie di condizioni ferree, come domande da non fare e richieste più o meno comprensibili da parte degli attori. Da una parte tutto si è semplificato grazie ad Internet ma d’altra parte tutto si è complicato, incasinato.
Suo padre era affascinato dal mondo circense. Organizzò la tournée del Circo di Mosca che venne anche ricevuta in Vaticano, un evento storico. E il giorno delle tue nozze le fece anche una proposta shock…
Non voleva che mi sposassi e mi propose un giro del mondo. Era davvero gelosissimo e per dieci anni, prima che nascesse mia sorella, fui anche figlia unica. Voleva che restassi per sempre la sua bambina ma onestamente era anche un po’ maschilista…
Ad un certo punto ricorda che suo padre, seduto alla cassa del Ciak con accanto il suo cane, le rimproverava di voler cambiar vita.
Intanto credo che in generale lavorare con i propri genitori sia difficilissimo. Nel migliore dei casi ci si vuole talmente bene che si finisce per litigare su tutto. Ma nel caso specifico, il problema è che lui amava moltissimo il rischio, era un vero incosciente, aveva milioni di idee che voleva mettere in pratica. E vi riusciva sempre. Al contrario io sono una persona che detesta il rischio. Anzi, forse lo sono diventata col tempo, prendendo le distanze da lui e da quella vita. Ma non metto in dubbio il fatto che il vero impresario privato, per avere successo, doveva agire esattamente come faceva lui, doveva amare il rischio.
Scrivi che se tuo padre avesse saputo in anticipo l’esito degli spettacoli sarebbe divenuto milionario ma si sarebbe annoiato. Per questo rifiutò il contributo pubblico per il Ciak. Ma decise anche di non seguire Mina, Celentano e abbandonò un locale importante come il Piper. Insomma fece scelte coraggiose.
Credo che Mina e Celentano li rifiutò perché non voleva fare l’agente, non voleva prendersi cura dei personaggi. E questa scelta, ammetto, la condivido in pieno. Io seguo i film come ufficio stampa ma non i singoli attori anche perché credo che sia un lavoro difficilissimo per il quale sei costretto ad annullare la tua personalità, mettendoti a totale disposizione del tuo assistito. Invece il Piper, penso che lo lasciò perché una discoteca, al contrario di un teatro, ad un certo punto porta con se un ambiente non proprio “pulito”. Altrimenti non si spiegherebbe perché d’improvviso, nonostante il successo, decise di lasciarlo.
Di tuo padre dice che lui ascoltava sempre tutti…ma poi faceva sempre di testa sua…
Assolutamente sì. Ma forse aveva anche ragione a fare così. Io all’inizio ero molto impreparata ma di sicuro mio padre, pur essendo una persona meravigliosa, non aveva un buon carattere e si fidava soltanto di se stesso. In fondo, sin dall’infanzia, dovette lottare sempre per affermarsi.
Eppure la tournée di Paul Anka nacque grazie a lei…
Ma in realtà credo che sia una leggenda metropolitana. Lui disse che ero stata io a convincerlo perché a me piaceva moltissimo ma credo che alla fine ci sarebbe arrivato lo stesso e visto che quell’operazione andò benissimo me ne diede il merito.
Dietro le figure di Jimi Hendrix e Frank Sinatra ci sono due aneddoti gustosi…
Jimi Hendrix doveva fare un concerto il pomeriggio ma non stava affatto bene, non si reggeva in piedi. E ovviamente nacquero mille leggende metropolitane su quale fosse l’origine del suo malanno… Ma la sera, i giornali raccontano, fece un concerto meraviglioso. Per quanto riguarda Sinatra accadde che il primo concerto andò malissimo mentre il secondo fu un successone e lui, da gran signore, pretese di coprire le spese del primo spettacolo. Ma successi e insuccessi, per un impresario privato, si alternano spessissimo. Delle volte organizzavi uno spettacolo e pensavi che non venisse nessuno eppure capitava che si formassero le file al botteghino perché, evidentemente, quello era il momento perfetto per organizzarlo. Altre volte invece eri convinto che sarebbe stato un successo, come nel caso di un grosso concerto di Franco Battiato al Palazzo dello Sport di Milano, e invece si rivelava un tremendo flop. Eppure Battiato era già famoso… Per questo poi gli venivano gli infarti…
A proposito della generosità di tuo padre, lei afferma che il periodo trascorso a Dachau ha sicuramente avuto un peso non indifferente…
Certamente. Però tengo a precisare che Dachau, quando lui fu lì, era ancora un campo di lavoro e non vi giunse perché ebreo ma perché suo padre era social-democratico. Ma di sicuro l’esser costretto a fuggire lo costringeva a cercare di vivere al massimo, aveva paura di non avere abbastanza tempo davanti. In realtà ha vissuto moltissimo e ha avuto grandi soddisfazioni ma da giovane ha cominciato a star male. Ha avuto ben 6 infarti e nell’82, a soli sessant’anni, ebbe un ictus importante. Era ancora molto giovane.
L’elenco degli artisti che dal ’77 in poi passarono da via San Gallo n°33, è davvero impressionante e molti di questi lo chiamavano Papà Leo.
Soprattutto lo faceva Jango Edwards, uno dei comici più divertenti e di successo di quel periodo. Papà non voleva che lui finisse nudo ma, inevitabilmente, alla fine lui si spogliava e poi andava da lui e gli diceva “Scusa Papà Leo”. Ma molti dei comici lo presero come un secondo padre perché gli volevano davvero molto bene e lo vezzeggiavano.
Suo padre ebbe la possibilità di lasciare l’Italia ma poi decise di abbracciare la causa partigiana e ciò lo portò a far conoscenza dell’intera famiglia Fo.
Conobbe casualmente Bianca che ricostruì nel suo libro questa storia e si nascose dal capostazione, che era il papà di Dario. Molti anni dopo, quando un giornale attaccò duramente Dario, papà lo andò difendere. Magari Dario vestiva davvero una divisa ma molti giovani, a quel tempo erano obbligati a farlo. Anzi, magari la vestivano per poter meglio aiutare i partigiani e Dario era un noto antifascista. Poi quando nacque il Ciak, Dario e Franca vennero spesso a lavorarci ma, come scrivo, il palcoscenico era davvero troppo piccolo. Ciò non toglie che quando lasciarono il Ciak mio padre si offese a morte e ci mise molto a perdonarli.
Il successo è sempre frutto di un insieme di tanti fattori. Ma secondo lei perché il Ciak era un luogo così speciale?
Il periodo trascorso al Ciak fu uno dei più belli della mia vita anche se alla fine non ne potevo davvero più, un teatro così ti costringe a viverci dentro senza alcuna pausa compresi Natale e Capodanno. Era un periodo fantastico dal punto di vista dello spettacolo perché rinascevano il mimo e un certo tipo di cabaret dopo un lungo periodo di calma piatta. La cosa bella è che da quell’esperienza sono nate anche vere amicizie come quella con Alessandro Bergonzoni.
Il suo personale ricordo di tuo padre è il primo di un lungo elenco con il quale si chiude il libro. Come mai lui per primo?
Perché Alessandro lascia “un rigo di silenzio” per ricordare mia sorella e in fondo questo libro è dedicato interamente a lei visto che quel lutto non l’ho mai davvero elaborato.
Solo nel 1966 suo padre divenne italiano e per questo fu costretto ad abbandonare il calcio e la medicina. Ma nonostante una vita così frenetica e ricca d’avventura suo padre ebbe sempre due rimpianti…
Barbra Streisand e il festival di San Remo. Della Streisand l’ho scoperto solo dopo, per quanto riguarda San Remo…ci mancava solo quello!
Fonte: Satisfiction del 14 ottobre 2010